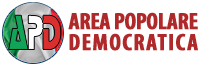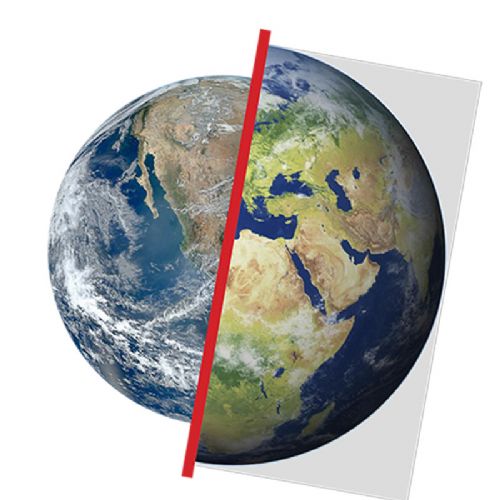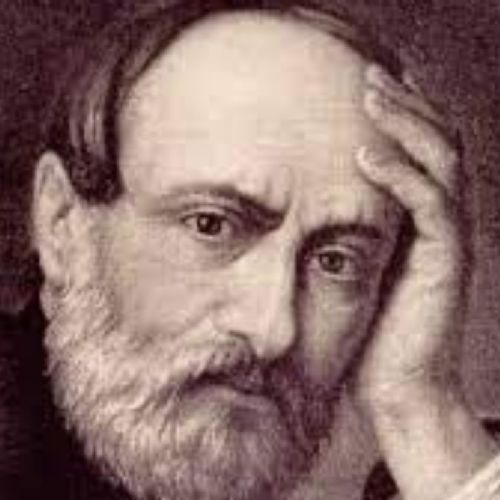Lettera aperta

Lettera aperta
Cari Amici,
la politica è in crisi e il marcato astensionismo ne è la prova più evidente: ormai c’è un cinquanta per cento dell’elettorato che non vota, determinando un grave vulnus al nostro sistema democratico.
A questo si aggiunge il dato che anche tra i votanti sono pochi quelli che partecipano al dibattito politico.
Gli attuali partiti non costituiscono più quel canale di partecipazione popolare prefigurato dalla nostra Costituzione.
La rappresentanza politica è ormai meramente virtuale: i territori non sono più rappresentati in Parlamento e molti deputati e senatori non hanno alcun rapporto con i rispettivi collegi elettorali.
La designazione dei candidati da parte dei leaders dei diversi partiti ha fatto parlare di un Parlamento di “nominati” che non rappresentano né i territori né gruppi di interessi, sono solo numeri destinati a votare secondo le direttive di capigruppo.
Questa situazione ha svilito il dibattito parlamentare e lo stesso ruolo del Parlamento.
Il moltiplicarsi di partitini impedisce quel dialogo che poteva svolgersi all’interno di grandi partiti popolari.
C’è insomma un vuoto di democrazia, manca un’offerta politica che possa dare all’elettorato concrete possibilità di scelta.
Da più parti, in Italia, si sente proporre l’ipotesi di una ricostituzione di un partito di ispirazione cristiana capace di collocarsi al centro dello schieramento politico; le ragioni di un tale intento risiedono innanzitutto sulla costatazione del ricordato astensionismo elettorale, che non può non porre il problema di una attuale insufficienza dell’offerta politica: è probabile che molti elettori si astengano dal partecipare al confronto elettorale, non sapendo a favore di chi poter esprimere né un voto di adesione né un voto di protesta.
Il dibattito politico, radicalizzato tra maggioranza e opposizione, si è ormai ridotto a un confronto rissoso, dove i ragionamenti sono sopraffatti dagli slogan e la faziosità delle argomentazioni non consente a tanti potenziali elettori di poter effettuare una scelta consapevole e condivisa.
C’è da chiedersi se il tendenziale e mai raggiunto bipartitismo, con la consequenziale logica dell’alternanza, possa garantire nel nostro Paese i risultati dei sistemi democratici di matrice britannica.
La tradizione inglese, e sino a qualche anno fa anche quella americana, si basava su un elettorato moderato intermedio che garantiva l’alternanza al governo; questo sistema assicurava il “congelamento” delle ali estreme, sicché per ottenere il successo elettorale i partiti dovevano intercettare l’elettorato moderato, presentando i candidati più vicini a questo settore intermedio.
Nel nostro Paese questo utile risultato, che dovrebbe garantire un governo essenzialmente moderato, non si è verificato giacché le coalizioni di destra e di sinistra determinano una logica inversa rispetto a quella che nei sistemi anglosassoni garantiscono compagini di governo di tipo moderato.
Infatti, le coalizioni lungi dal “congelare” le ali estreme, finiscono per esaltarle, in quanto i partiti all’interno delle coalizioni sono in realtà in concorrenza tra loro sul piano elettorale, il che fa sì che i partiti più moderati temono di essere scavalcati rispettivamente a destra o a sinistra; insomma, le ali estreme che nel sistema inglese tendono ad essere ininfluenti, nel nostro sistema invece, risultano determinanti.
Naturalmente su questo incide anche il sistema elettorale, infatti la democrazia dell’alternanza di tipo britannico si basa su di un sistema di collegi uninominali dove sono proprio i candidati più moderati ad attrarre l’elettorato intermedio, al contrario nel nostro sistema tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione, quindi anche quelli più estremisti, hanno titolo ad essere proporzionalmente rappresentati.
Ora, abbandonata l’ipotesi di un bipartitismo italiano e valutata la carenza di offerta politica costituita dalle coalizioni, potrebbe riproporsi la costituzione di un solido partito di centro nell’ambito del quale poter avviare un dibattito interno capace di rifuggire dalle sclerotizzazioni sloganistiche, che invece rappresentano la triste realtà del confronto politico attuale.
Anche all’interno dei partiti attuali non sembra esserci un confronto democratico e un corrispondente dibattito, essendo la nuova logica partitica tutta incentrata su dei leaders, sostanziali padroni dei rispettivi partiti.
Anche all’interno delle coalizioni il dibattito tra i partiti aderenti non appare costruttivo giacché, come si è detto, il confronto rimane finalizzato ad un immediato vantaggio elettorale più che al miglior governo del Paese.
In questa fase storica è fondamentale poter affrontare i tanti problemi che si affacciano in questo mondo così travagliato nell’ambito di un dibattito che può essere costruttivo solo tra quanti condividono fondamentali valori etici e sociali, dove non contino destra e sinistra ma la ricerca di soluzioni ragionevoli in linea con i sentimenti e le volontà di tutti i potenziali elettori.
Si può pensare ad una convention di tutti i partiti e movimenti di ispirazione cristiana per arrivare gradualmente alla configurazione di un soggetto politico unitario capace di rivolgersi anche a quella parte di elettorato che oggi si astiene a fronte di proposte politiche spesso demagogiche e comunque orientate soprattutto a combattere l’avversario anziché essere propositive sui tanti temi che affollano non solo l’attualità ma anche l’immediato futuro.
Qui di seguito sintetizzo le analisi e le proposte di un gruppo di lavoro (del quale anch’io faccio parte) coordinato da Mons. Vincenzo Paglia che è arrivato alla conclusione che i problemi della politica italiana non possono più essere affrontati nella dimensione meramente nazionale e che c’è la necessità di impegnarsi a livello europeo, il che significa affrontare anche il tema della crisi che sta attraversando l’Unione Europea.
Questi gli argomenti: 1. Rilanciamo l’ideale europeo; 2. La prospettiva di una Europa federale; 3. Le fondamenta cristiane dell’Europa; 4. Il lavoro come diritto e la dottrina sociale della Chiesa; 5. Il problema della crescita economica dell’Europa; 6. Un nuovo welfare per un’Europa solidale; 7. Welfare e lavoro: un rapporto da ripensare; 8. Uno sviluppo economico equilibrato tra i paesi europei; 9. Una strategia europea per le risorse energetiche; 10. La politica migratoria.
1. RILANCIAMO L’IDEALE EUROPEO
L’Ue rappresenta una storia di grandi successi. Grazie ad essa, l’Europa ha potuto rialzarsi dalle macerie della guerra, ha potuto fare i conti con la vergogna del suo razzismo, ha potuto crescere economicamente, ha potuto rendere le proprie democrazie solide perché sostenute dallo stato di diritto, ha potuto dotarsi delle risorse per costruire sistemi sociali di protezione che, nonostante i difetti, non hanno eguali al mondo. Chi vuole disfarsi di questa esperienza è un ignorante oppure un irresponsabile. Eppure, nonostante i successi, l’Ue ha manifestato limiti nel suo funzionamento, ma anche nella narrazione relativa alle ragioni della sua esistenza.
Nessun Paese può affrontare, da solo, l’aggressione militare di una grande potenza, una crisi finanziaria globale, una pandemia che non conosce confini, un’immigrazione spinta dalla miseria e dalla violenza. Ecco perché è necessario che si formi in Europa un attore collettivo, organizzato secondo una logica federale di separazione multiple dei poteri, capace di agire in nome di un interesse e di una visione sovranazionale. Alla cupezza e alla chiusura perseguite dalla narrazione nazionalista, occorre opporre l’apertura e la generosità di un’Europa che guarda al futuro. Non si può lasciare ai nazionalisti il cuore, oltre che le menti, dei cittadini europei.
L’Europa è di fronte ad una svolta perché se, per un verso, si trova ad affrontare una sfida estremamente difficile, ha un’occasione non rinviabile di perseguire quell’autonomia strategica che è essenziale per realizzare il cammino dello sviluppo sostenibile, va garantito il diritto per tutti alla salute e all’istruzione, nella lotta contro le disuguaglianze, la povertà e la fame, nonché l’esercizio delle azioni necessarie a favore di clima, ambiente e parità di genere.
Le democrazie contemporanee sono molto vulnerabili agli “argomenti facili”, stereotipi ed emozioni che tendono a prevalere nel dibattito di oggi e sono strumento di consenso populista. Il venir meno delle ‘grandi ideologie ha reso difficile per i partiti politici assicurarsi la fedeltà degli elettori e li ha portati ad affidarsi “a tecniche di persuasione e di marketing che mantengono e riproducono una forte polarizzazione”. La conseguenza è che oggi siamo di fronte ad un “malessere” che ha messo in campo un confronto generale tra la democrazia rappresentativa e la sua versione “populista”.
Per vincere questa sfida occorre che i cittadini europei siano visti in una prospettiva del “noi” che si associ alla cura degli interessi di tutta la comunità europea e non solo di quelli dei propri connazionali e riprendere il ruolo, che nella storia ci è stato proprio, di dialogo e di confronto.
È l’ottica giusta per riprendere, a livello europeo, uno spirito di confronto che richiami quello della “Rerum Novarum”. Di questo c’è un gran bisogno in un momento come questo in cui non si intravede l’ispirazione, quanto mai necessaria, per un “progetto europeo” all’altezza della sfida dei tempi.
2. LA PROSPETTIVA DI UNA EUROPA FEDERALE
Nata come un Patto per la pace interna, l’Ue si è trovata impreparata ad affrontare le guerre esterne. Nata come un Patto per la libertà, l’Ue si è trovata priva di strumenti per contenere gli attacchi allo stato di diritto provenienti dall’interno stesso dei suoi stati membri. Con i progressivi allargamenti, la solidarietà interna si è progressivamente indebolita, a vantaggio degli egoismi nazionali. Nata per addomesticare i nazionalismi, l’Ue è sempre più prigioniera di quest’ultimi, il cui esito è la crescita delle divisioni interstatali sotto le pressioni di crisi esistenziali. Il progetto integrativo, che ha condotto all’Ue, viene non solamente sfidato (sul piano istituzionale e delle policies), ma anche delegittimato (sul piano storico e morale).
L’Europa occidentale era uscita dalle guerre dandosi una nuova identità politica, con la sovranità popolare sottoposta ai vincoli della sovranità costituzionale e dell’integrazione sovranazionale. Sia la sovranità economica che quella politica dovevano essere contenute attraverso reciproche interdipendenze tra gli stati.
Il ruolo della Commissione europea è stato ridimensionato, trasformata in un’agenzia tecnica al servizio del Consiglio europeo, non già preservata nel suo ruolo di attore-guida del processo di integrazione come nelle politiche regolative del mercato unico. Il ruolo delle altre due istituzioni sovranazionali è stato ancora di più ridimensionato. Consistendo, il processo deliberativo, di decisioni politiche e non legislative, non solamente il Parlamento europeo ha finito per essere escluso dal policy-making, ma anche il ruolo della Corte europea di giustizia è stato ridimensionato. Insomma, nelle politiche strategiche, si è affermato un modello di governance molto diverso da quello sovranazionale.
In questa trasformazione dell’Ue, le leadership europeiste si sono rinchiuse sempre di più in una prospettiva tecnica dell’integrazione. Influenzate dalle predominanti narrative relative a quest’ultima, l’Ue è stata presentata come un sistema di sviluppi funzionali oppure come un’arena per coordinare le preferenze dei governi nazionali.
L’Ue è diventata progressivamente “fredda”, anche se calde sono state le crisi che ha dovuto affrontare. L’interesse dei governi nazionali oppure quello degli attori sovranazionali ha preso il posto del dibattito sulle ragioni per cui si sta insieme. Si è imposta l’economia, si è eclissata la politica. L’emozione che era negli occhi dei Padri fondatori (che avevano conosciuto sulla loro pelle la guerra) è divenuta progressivamente apatia nelle generazioni successive.
È probabile che non tutti gli stati membri dell’Ue (le loro élites e i loro cittadini) siano disponibile a partecipare ad un progetto di federalizzazione. Per questo motivo, quest’ultimo dovrebbe essere perseguito all’interno di una strategia, altrettanto pluralista, che preveda forme differenziate di aggregazione (ad esempio, un primo cerchio intorno a tematiche di comune interesse, un secondo cerchio intorno ad un mercato comune, un terzo cerchio intorno ad una politica comune). La federalizzazione di quest’ultima, se è finalizzata a creare un’autorità dotata delle capacità per agire autonomamente, può aiutare l’intero continente ad uscire dalla minorità politica, non solamente sul piano della sicurezza.
Tale autorità deve essere però dotata della legittimazione democratica per poter esercitare il suo ruolo, legittimità che può provenire solamente da una partecipazione dei cittadini alla formazione delle istituzioni che la costituiscono.
In questo modo, l’interesse collettivo potrà essere oggetto di dispute e contrasti, così da rendere evidente la posta in gioco del processo di legittimazione. Occorre creare una sfera pubblica europea, distinta da quella nazionale, in cui il pluralismo si possa trasformare in orientamenti politici maggioritari, nel rispetto costituzionale degli orientamenti (momentaneamente) minoritari. Un’Europa federale all’interno di un’Europa plurale, entrambe impegnate a promuovere un sistema globale multipolare, l’unico coerente con le loro logiche di funzionamento, così contrastando i nazionalismi imperiali delle grandi potenze.
3. LE FONDAMENTA CRISTIANE DELL’EUROPA
L’ambizione di queste considerazioni è, dunque, quella di gettare le basi per una vera e propria rivoluzione culturale cristiana, che non pretende egemonia ma offre testimonianza; che non si impone ma si propone; che non ha paura di misurarsi con il pensiero laico, purché questo sia serio, critico e costruttivo. E per farlo, serve una Chiesa “in uscita”, come auspicava Francesco, ma anche un’economia del bene comune e una politica istituzionale che non abbia paura dell’integrazione federale. L’Europa ha ancora le risorse per essere uno spazio di convivenza pacifica e giustizia sociale, ma deve avere il coraggio di ritrovare le proprie radici per poter guardare avanti.
In conclusione, è necessario che si formi in Europa un attore collettivo, organizzato secondo una logica federale di separazione multiple dei poteri, capace di agire in nome di un interesse e di una visione sovranazionale. Alla cupezza e alla chiusura perseguite dalla narrazione nazionalista, occorre opporre l’apertura e la generosità di un’Europa che guarda al futuro. Un’Europa capace di preservare sé stessa e il suo sistema di valori.
È urgente una ripresa di iniziativa nel contesto della formazione di una politica europea adeguata all’umanesimo spirituale della comunità che in questo momento storico può assumere il rilievo di questione epocale. Le politiche prevalenti appaiono sempre più polarizzate sull’umanesimo materiale della collettività.
L’Europa è il campo nel quale il cristianesimo ha più storia, più esperienza, più invenzione. Ebbene proprio questa eredità deve interpellare i cristiani europei di questo tempo perché riprendano il tesoro di fede e di umanesimo nelle loro mani e sveglino un’Europa che si sta frantumando in egoismi sovranisti.
Di fronte a questi scenari inquietanti, il cristianesimo europeo deve ritrovare una sua missione proattiva, direi profetica, per delineare un orizzonte umanistico planetario che solo può aprire un futuro pacifico. È urgente riprendere l’iniziativa per aiutare la crescita di una cultura politica europea adeguata all’umanesimo spirituale della comunità che in questo momento storico può assumere il rilievo di questione epocale.
Un cristianesimo europeo che vuole essere all’altezza della situazione deve chiudere la fase delle lamentazioni per l’indebolimento di una forma di assistenza spirituale della cittadinanza propria della chiesa-di-stato e della religione civile.
Il riconoscimento dei diritti umani ha radici europee. E appartiene alla tradizione europea il legame tra l’esercizio del potere e la protezione dei cittadini: dai re taumaturghi medievali al moderno welfare state, in Europa il potere è chiamato a prendersi cura della vita degli uomini e delle donne che la popolano.
L’unità europea si basa su uno scambio tra indipendenza e sovranità: gli Stati europei cedono quote di indipendenza alle istituzioni comunitarie per difendere collettivamente le loro sovranità.
Sarebbe disumano, ingiusto e pericoloso ignorare le loro richieste e, del resto, i migranti costituiscono risorse lavorative di cui l’Europa ha bisogno. Ma è chiaro che un fenomeno di dimensioni straordinarie ed epocali come questo può essere affrontato solo dagli europei tutti insieme, attingendo a risorse non solo economiche e politiche ma anche ideali e morali.
La “dottrina sociale” della Chiesa conserva l’idealità di un “bene comune” che nella complessità e nella frammentazione odierna non trova referente adeguato.
Il cristianesimo ha la forza per ispirare una società democratica che pone al centro la qualità della persona umana. Il cristianesimo che ha proiettato l’Europa nell’orizzonte planetario è forse il solo – oggi – che può rianimarla dal ripiegamento nella quale è precipitata: una società senza più sogni – qualcuno dice anche senz’anima - e rassegnata a frammentarsi. Il cristianesimo può ridarle vigore, può liberarla dalla prigionia dell’Io e suscitare uno spirito che generi il “Noi”, che faccia esistere ciò che ancora non c’è, realizzandolo in forme organizzative e istituzionali. C’è bisogno di una creatività nuova. Vanno avviati processi di cambiamento, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni chiamate a rinascere, lasciandosi alle spalle il mondo che la generazione dei baby-boomers ha costruito e diventando protagonisti di un nuovo modo di vedere, di immaginare, di vivere.
4. Il lavoro come diritto e la dottrina sociale della Chiesa
Si deve prendere coscienza che ogni mutamento della realtà socioeconomica incide sulle stesse categorie giuridiche poste a base dei valori sociali. Bisogna anche guardare al magistero della Chiesa che ha sempre avuto la capacità di cogliere l’attualità di determinati valori, così da farne un punto fermo, un imprescindibile riferimento per la politica e l’economia. Basti ricordare la Rerum Novarum di Leone XIII che nell’ambito di un sistema di assoluto capitalismo ha esaltato i valori della democrazia e dell’associazionismo sindacale dando legittimazione morale alle rivendicazioni dei lavoratori.
Nella Laborem Exercens Giovanni Paolo II pose il concetto dello Stato come primo datore di lavoro indiretto, che deve condurre a una giusta politica del lavoro. In tale enciclica si denunciava il fatto che “Paesi altamente industrializzati e più ancora, le imprese che dirigono su grande scala i mezzi di produzione industriale (le cosiddette società multinazionali o transnazionali) dettano i prezzi più alti possibili per i loro prodotti cercando contemporaneamente di stabilire i prezzi più bassi possibili per le materie prime o per i semi-lavorati… Il datore di lavoro, trovandosi in un simile sistema di condizionamenti, fissa le condizioni del lavoro al di sotto delle oggettive esigenze dei lavoratori, specialmente se egli stesso vuole trarre i profitti più alti possibili dall’impresa da lui condotta.” (par. 17/B).
Benedetto XVI con la Enciclica Caritas in Veritate nel giugno del 2009 riprende le ampie tematiche della Populorum Progressio di Paolo VI. In tale enciclica viene posta l’esigenza di soluzioni nuove, alla luce di una visione integrale dell’uomo “La dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono che soprattutto oggi le scelte economiche non facciano aumentare in modo eccessivo e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza, e che si continui a percepire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti… L’abbassamento del livello di tutela dei diritti dei lavoratori o la rinuncia di redistribuzione del reddito per fare acquistare al Paese maggiore competitività internazionale, impediscono l’affermarsi di uno sviluppo di lunga durata.” (par. 22).
Da ultimo l’Enciclica di Papa Francesco Laudato Si ha coniugato i problemi ecologici con quelli sociali ed ha affermato che “rinunciare ad investire sulle persone per un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la società” ricordando che è il lavoro che dà un senso alla vita dell’uomo. Il magistero papale ha sempre richiamato la fondamentale importanza del lavoro a garanzia della dignità umana, pertanto non è finanziando la disoccupazione che si fa il bene delle persone ma garantendo il loro diritto al lavoro.
I caratteri di base dell’agire politico dei cattolici in ultima analisi possono essere riepilogati nei seguenti punti:
· fede in libertà-uguaglianza-fratellanza; fede nella democrazia; fede nella solidarietà; fede nella religione civile;
· personalismo; primato delle relazioni espresse per sua natura dalla persona umana; favore per il perfezionamento nei vari gradi di associazione umana, dalla famiglia al contesto collaborativo del lavoro, ai corpi intermedi, alla società civile nel suo insieme;
· primato della materia sociale; contrasto dei mali sociali con gli investimenti sociali; presenza del connotato di utilità sociale in connessione ai tanti snodi della vita associata;
· rifiuto della ideologia e delle schematicità precostituite, da ripetere acriticamente; rifiuto della demagogia e di ogni forma di manipolazione;
· favore per l’associazionismo sociale e civile; le associazioni, sono corpi intermedi, sono il luogo dove discutere i termini del perfezionamento/miglioramento di cui ogni persona è alla ricerca;
· ammissione della morale nel trattare e approfondire la materia sociale, la materia economica, la materia politica, i contenuti morali e civili debbono fare da cornice al pensiero sociale, al pensiero economico e al pensiero politico;
· valorizzazione dello Stato di diritto; questa piega del vedere le cose Leone XIII la auspica anche (e soprattutto) nella relazione, anarcoide e non regolata, tra nazioni;
· dovere di solidarietà; priorità dell’attenzione da tributare ai meno fortunati, ai meno abbienti, a chi è più in difficoltà, ai più colpiti da sventure, organizzando misure concrete;
· etica dei doveri ed etica delle responsabilità; ricerca della pace nell’ambito di un progetto di ingegneria sociale volto al superamento della miseria.
5. IL PROBLEMA DELLA CRESCITA ECONOMICA DELL’EUROPA.
L’Europa soffre di un rallentamento di crescita e produttività che richiede un deciso intervento per la sua ricollocazione nel quadro competitivo internazionale.
La riduzione dei vantaggi nei rapporti di scambio tra prodotti energetici, minerali e manufatti sin qui goduti vede, non a caso, il maggior Paese, la Germania, in crisi.
Ne risentono in generale i Paesi dell’eurozona che rischiano di non poter sostenere il proprio welfare costoso soggetto anche ai gravami dell’invecchiamento della popolazione.
L’Europa sta percorrendo una transizione di lungo periodo che l’ha portata, dai tempi in cui deteneva il primato dell’innovazione finanziaria e tecnologica, ad un ritardo nell’adozione dell’High-tech.
L’enfatizzazione dell’automazione e lo spiazzamento del lavoro di certo favoriscono l’aumento delle disuguaglianze. Ma un’IA generativa, che sia complementare al lavoro e aumenti le competenze, insieme a politiche che facciano aumentare gli skill anche di chi non ha goduto di una formazione universitaria, può essere un antidoto rispetto alle disuguaglianze.
La grande questione che abbiamo oggi davanti a noi è che, di fronte alla nuova grande trasformazione in corso, quella del digitale, delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale, non abbiamo ancora elaborato una risposta adeguata.
In questo quadro, è evidente l’esigenza di ripensare i sistemi di welfare, assicurando le necessarie condizioni di equità e di inclusione sociale. È certo un’esigenza difficile da realizzare in un mondo segnato da una competizione sempre più aspra, in cui vengano a mancare i principali meccanismi di riequilibrio delle forze di mercato. Basti pensare ai sistemi antitrust nati per evitare il prevalere delle posizioni dominanti sul mercato, e oggi assai poco influenti, tanto che il ruolo delle grandi imprese High-tech negli USA, quali Meta, Google, Microsoft, Amazon, OpenAI, è stato definito come quello di una potenziale tecno-oligarchia.
Osservando i cambiamenti in corso, sia in termini di nuove disuguaglianze che di occupazione, dobbiamo prendere atto che il welfare state, nella sua configurazione attuale, non è più sufficiente a fronteggiare i nuovi bisogni di inclusione e sicurezza sociale. Ci sono i garantiti della società industriale ma, allo stesso tempo, ci sono gli esclusi per via dei cambiamenti della domanda di skill del manifatturiero che, come abbiamo visto, chiede competenze maggiori di quelle medie richieste in passato. Non solo, ma l’aumento del peso dei servizi nel prodotto nazionale si accompagna alla domanda di nuove professionalità che spiazza le competenze in essere.
L’insieme di coloro che, a causa delle basse qualifiche, non hanno un posto di lavoro stabile e sono senza risorse economiche alternative, ha creato una nuova classe, quella del “precariato”35, fatto di coloro che escono ed entrano nel mercato del lavoro senza alcuna stabilità occupazionale. La questione è che per loro, in mancanza di meccanismi di inclusione, non funziona l’ascensore sociale. E che, mancando delle risorse necessarie, non riescono ad acquisire le competenze richieste da un mondo in cambiamento.
Il rimedio non può che essere una rivisitazione delle provvidenze del welfare state non solo a livello nazionale, ma anche a livello dell’Unione europea. Anche perché, in alcuni casi, il precariato nasce da scelte d’impresa che spostano la propria attività da un Paese dell’Unione ad un altro, dove gli incentivi alla localizzazione assicurano migliori condizioni di redditività.
È necessario, dunque, che la UE - se vuole proporsi come un’area del mondo che torna ad essere attrattiva, si faccia carico di questi problemi. Nel ripensare il welfare state, occorre tener conto, inoltre, del peso crescente che grava sui suoi conti per via dell’invecchiamento della popolazione che, come abbiamo visto, determina un aumento delle spese per sanità e previdenza. Una condizione necessaria perché i sistemi di welfare riescano a far fronte ai nuovi compiti che gli sono consegnati dalla grande trasformazione che stiamo vivendo, è che le economie europee realizzino gli aumenti di produttività necessari a consegnare a sanità, previdenza e istruzione le risorse per ottenere l’equità e l’inclusione sociale necessarie.
All’Europa serve una società non solo più inclusiva ma anche più dinamica; è un obbiettivo, quest’ultimo, che può raggiungere con una ripresa della sua tradizione di attore globale sulla scena del mondo non solo attraverso gli scambi e il suo contributo alla ridefinizione dell’ordine economico internazionale ma anche attraverso investimenti condivisi con i Paesi emergenti su ricerca e nuove tecnologie che sono all’origine dei cambiamenti in atto nel mondo, oggi. Si tratta di contribuire, anche per questa via, all’innesco e alla diffusione dei processi di innovazione.
6. UN NUOVO WELFARE PER UNA EUROPA SOLIDALE
Non può più essere il lavoro, con il correlato sistema di contribuzione individuale, a garantire il welfare che dovrà essere gradualmente portato ad una completa fiscalizzazione, anche in relazione ad una prevista non sostenibilità dei sistemi previdenziali a ripartizione, essendo in crisi il sistema di solidarietà intergenerazionale a causa del precariato e della denatalità.
I diritti sociali per potere essere garantiti, a prescindere dal contesto economico, hanno bisogno di essere concepiti nella loro essenza tesa alla tutela diretta della persona e non condizionati dall’intreccio delle diverse politiche economiche, fiscali e monetarie che sono alla base degli interventi occupazionali e di etero-regolamentazione del mercato.
Insomma, oggi il welfare, secondo la nostra prospettiva, è destinato a prescindere dal lavoro di scambio retribuito e si pone il problema di come legittimare una ripartizione del reddito in una società che anche a fronte della crescente automazione e della utilizzazione dell’intelligenza artificiale vedrà crescere la disoccupazione e ciò anche a fronte di un aumento del PIL.
L’Europa necessita di un nuovo assetto istituzionale capace di garantire benessere e lavoro per tutti i cittadini. Non tutti i lavori debbono avere necessariamente una retribuzione correlata al mercato; esistono infatti lavori utili alla società e non valutabili in termini di valore aggiunto.
Va combattuto il dumping sociale operato anche tra i paesi europei e quindi si deve tener conto dei costi di contesto che affrontano i singoli lavoratori inseriti in realtà economiche diverse; saranno pertanto gli Stati colpiti da questa indebita concorrenza ad integrare le retribuzioni dei propri lavoratori, così evitando la delocalizzazione delle proprie aziende.
La previdenza non può più essere l’ombra del reddito da lavoro ma va rovesciato il rapporto: il welfare per tutti e la garanzia del lavoro anche fuori mercato (si pensi ai lavori socialmente utili).
È antieconomico ed umiliante per i lavoratori la politica di sussidiare la disoccupazione, quando le stesse risorse potrebbero invece garantire una stabile occupazione.
Si può pensare per determinate produzioni, messe in crisi dalla concorrenza globale, a un mix tra retribuzione di scambio e salario sociale, così da evitare la chiusura delle aziende o la loro delocalizzazione.
La sicurezza sociale e in generale i sistemi previdenziali debbono poter essere finanziati dalla fiscalità generale in una situazione in cui paradossalmente non c’è più un rapporto tra occupazione e PIL: si assiste infatti in molti contesti ad un aumento della ricchezza collettiva a fronte di situazione di disoccupazione e di precariato.
Il corrispettivo del lavoro deve poter essere la garanzia del benessere del lavoratore, con particolare riguardo al ruolo della maternità, c’è bisogno di una riforma del welfare capace di costruire modelli flessibili di lavoro e di assistenza per risolvere il drammatico problema della denatalità europea.
Il lavoro va ricercato e garantito anche al di là della sua redditività ed è questo che gli Stati debbono garantire in un contesto europeo.
7. welfare e LAVORO: UN RAPPORTO DA RIPENSARE
Il problema è quello di passare da un reddito di solo scambio ad un reddito di solidarietà garantito dallo Stato, cosicché una qualsiasi attività socialmente utile sia meritevole, quantomeno di un reddito minimo, a prescindere dal suo valore economico sul mercato.
L’esperienza dei lavori socialmente utili come misura universale destinata ai disoccupati di lunga durata, potrebbe essere ripresa e riproposta a livello europeo.
La garanzia dei bisogni essenziali della persona costituisce il primario compito degli Stati, mentre al suo esordio la sicurezza sociale era nata come una necessità correlata all’industrializzazione e tutto il sistema previdenziale si è sviluppato solo nell’alveo della società industriale e la previdenza è stata definita l’ombra del rapporto di lavoro.
Oggi invece il rapporto tra lavoro e previdenza va in qualche modo rovesciato, il welfare deve garantire a tutti una vita dignitosa dove il lavoro sarà il suo fondamentale complemento, e non ne dovrà condizionare gli aspetti di sicurezza sociale.
In questa prospettiva il welfare diviene un concetto autonomo non direttamente correlato al rapporto di lavoro; il capitale in alcuni casi sembra poter addirittura prescindere dall’occupazione e si arriva a parlare di crescita economica senza un correlativo incremento occupazionale, infatti in molti casi il PIL degli Stati aumenta anche a fronte del paradossale corrispondente aumento della disoccupazione.
La società post-industriale postula una concezione del lavoro visto innanzitutto nella sua funzione di realizzazione della persona e volto anche al perseguimento di obiettivi di crescita morale e culturale della società.
Ai processi di automazione non è seguita una politica di incentivi verso lavori fuori mercato, comunque indispensabili in una progredita società post-industriale. Oggi la logica economica ha finito per relegare gli interventi a sostegno del reddito in ipotesi di crisi delle imprese sussidiando la disoccupazione cercando di garantire la continuità di un reddito che trova la sua base pur sempre nel parametro lavoristico.
Ora, il problema della riforma del welfare va affrontato prendendo in considerazione la ipotesi di un mix tra reddito da lavoro e reddito assistenziale capace di dare ad ogni cittadino la propria dignità di lavoratore, rimanendo inserito a pieno titolo nel contesto sociale del proprio Paese.
Grazie agli interventi statali volti ad integrare il reddito da lavoro così da garantire ai lavoratori i costi di contesto (la vita in Germania costa più che in Romania) si eviterebbero le delocalizzazioni; se si considera che il mantenimento dell’occupazione potrà evitare le provvidenze per la disoccupazione non dovrebbe determinarsi un eccesso di spesa per i bilanci statali.
Insomma sussidiare il lavoro (e la conseguente etica sociale) sembra più opportuno che sussidiare la disoccupazione.
Inoltre va considerato che attualmente il finanziamento del welfare in Europa è tuttora regolato da meccanismi basati su categorie concettuali di origine ottocentesca.
I sistemi delle assicurazioni sociali sono finanziati dalle contribuzioni che le aziende pagano agli istituti previdenziali, calcolandoli su una percentuale della retribuzione, e queste risorse sono destinate a garantire il sistema pensionistico.
I sistemi previdenziali, deputati ad assicurare la pensione ai lavoratori che raggiungono una determinata età, sono per la maggior parte sistemi a ripartizione, basati quindi sulla solidarietà intergenerazionale, sicché una generazione di lavoratori con i propri contributi mantiene la precedente generazione di pensionati. Questi sistemi a ripartizione (a differenza di quelli a capitalizzazione dove i contributi vengono accantonati ed investiti e che rappresentano la massa monetaria destinata a mantenere i singoli pensionati) non prevedono accantonamenti sicché i contributi vengono immediatamente riversati al finanziamento delle pensioni.
Disoccupazione e denatalità stanno, però, mettendo in crisi questi sistemi e presto, perdurando gli attuali indici di natalità, si arriverà al rapporto di un lavoratore attivo per un pensionato e in questa condizione è di tutta evidenza che i sistemi a ripartizione non potranno garantire la erogazione dei trattamenti pensionistici.
Oggi sono le imprese labour intensive a finanziare i sistemi di welfare giacché i contributi vengono erogati dalle aziende sulla base del numero degli occupati; ma è noto che le imprese che impiegano molto personale sono quelle che hanno una redditività scarsa a fronte di imprese che con pochi addetti riescono ad avere i maggiori ricavi.
Il sistema aveva una sua razionalità in una concezione marxiana del valore dove, appunto, il valore di un bene era determinato dal lavoro incorporato nei prodotti, cioè da tutto quel lavoro che era stato necessario per produrlo. Ora è palese che non è più così, il convulso processo di innovazione dei beni tecnologici contrasta con il valore di un bene durevole e l’automazione dei sistemi di produzione non ha più alcun diretto rapporto con il numero degli addetti.
Se quindi è cambiato il contesto produttivo e di mercato, la previdenza è però rimasta ancorata ad una diversa realtà, quella nella quale il welfare era, ed è tuttora, finanziato in ragione del numero degli addetti con le contribuzioni calcolate sulla retribuzione del singolo lavoratore.
Sembra pertanto imprescindibile l’esigenza che il welfare debba venire ad essere garantito dalla fiscalità generale, proprio in considerazione del fatto che spesso piccole e medie imprese con pochi dipendenti hanno oggi, in alcuni casi, una redditività maggiore rispetto a imprese costrette ad impiegare un numero elevato di addetti.
Già oggi la previdenza in Italia è in parte fiscalizzata ed infatti il bilancio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è integrato per circa un trenta per cento dallo Stato.
Sebbene oggi il tasso di disoccupazione sia relativamente basso, gli sviluppi dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di automazione potrebbero già portare, se generalizzati, a ridurre l’occupazione nell’industria e nei servizi del cinquanta per cento.
Si porrà quindi a breve il problema di una vasta disoccupazione, e che inevitabilmente tarderà ad essere riassorbita dall’impiego indotto dalle nuove tecnologie; pertanto la soluzione dovrà essere trovata nel potenziamento delle attività labour intensive proprie di quei settori che per loro natura non potranno essere surrogati dalle macchine, ma certamente non potrà essere garantita da quest’area occupazionale a scarsa redditività la garanzia delle risorse per l’equilibrio pensionistico.
Oltre alla denatalità anche l’allungamento della vita media non consentirà di mantenere gli attuali assetti normativi propri del sistema previdenziale, da qui la necessità di una riforma del finanziamento del welfare non più a carico delle imprese labour intensive ma finanziato dalle imprese più produttive e quindi dalla fiscalità generale.
8. uno sviluppo economico equilibrato tra i paesi europei
In questo contesto è impellente la necessità di dare una anima all’Europa, nel senso di avviare il passaggio da un’unione che garantisce l’unicità del mercato ad un soggetto capace di descrivere una comunità. Attualmente l’Europa, pur imponendo agli Stati l’estensione a tutti i cittadini europei dei diritti previdenziali, non prevede, però, direttive tese a unificare le politiche di welfare, quando invece i principi solidaristici, che proprio nelle politiche di sicurezza sociale si esprimono, costituiscono l’essenza di quella base solidaristica che rappresenta il substrato essenziale di una comunità.
Lungi dal prevedere una omogeneizzazione dei sistemi di welfare, alcuni Stati europei conducono politiche di dumping sociale, così da attrarre imprese e conseguenti opportunità occupazionali.
Il problema delle delocalizzazioni affligge i paesi europei più evoluti che vedono desertificate aree industriali in favore di altri paesi che attirano attività industriali grazie ai bassi salari e alle facilitazioni fiscali.
La logica del libero scambio e della globalizzazione costituisce indubbiamente il presupposto per la costruzione di una realtà politico-economica, ma l’Europa deve fare un salto di qualità: dalla logica del mercato unico deve passare alla costruzione di una comunità capace di esprimere una nazionalità europea.
Naturalmente la latente conflittualità che contrappone gli Stati nazionali a fronte della concorrenza sul piano fiscale, delle retribuzioni salariali e del welfare, debbono trovare un componimento nell’interesse di tutti gli Stati e delle loro rispettive economie.
È fisiologico che le imprese si delocalizzino in quegli stati dove il costo del lavoro è più basso ed è questo positivo per lo sviluppo economico dei paesi anche europei meno progrediti, ma è comunque necessario un bilanciamento non potendo gli stati che soffrono della delocalizzazione rinunciare ad una quota di industrie manifatturiere.
L’obiettivo è quello di avere un tessuto industriale europeo dislocato equamente tra i diversi stati, forse si dovrebbe fare per l’industria quello che si è fatto per l’agricoltura: se si è evitata la desertificazione agricola si dovrà pensare anche ad evitare la desertificazione industriale.
Per creare delle comunità coese capaci di rispondere a tutte le necessità occupazionali e di vita dei propri cittadini, è necessario contrastare a livello europeo la tendenza a specializzare le produzioni, va infatti evitato che in alcuni Stati sia sviluppata l’agricoltura, in altri l’industria pesante, in altri l’industria manifatturiera, in altri l’innovazione tecnologica e la ricerca. Per creare una società in equilibrio, sia all’interno di ciascuno Stato che nei confronti degli altri Stati europei, è imprescindibile la creazione di condizioni di sviluppo omogenee: e per questo ciascun paese deve sviluppare tutti i settori economici capaci di dare occupazione ad ogni categoria di potenziali lavoratori, siano essi agricoltori, operai dell’industria, dei servizi, della ricerca ecc.
Per garantire tali obiettivi non ci si può rimettere passivamente alla sola logica del mercato che, come si è visto, consente la delocalizzazione delle imprese secondo logiche incompatibili con la costruzione di un tessuto sociale integrato ed omogeneo, capace di portarci ad un’Europa unita non solo da una logica di mercato ma anche da un sistema di valori che solo una società in equilibrio può assicurare.
Ora, questo equilibrio sociale va perseguito a livello europeo evitando che in un paese si faccia solo finanza, in un altro solo agricoltura e in un altro ancora solo manifatturiero e i correttivi debbono essere necessariamente approntati dagli apparati legislativi europei e statali.
La logica delle specializzazioni economiche nelle varie regioni europee, se da una parte riguarda la delocalizzazione delle imprese, dall’altra incide sui flussi migratori all’interno dell’Unione Europea. Questo fenomeno, se da una parte può essere visto favorevolmente nell’ottica della integrazione culturale delle popolazioni dei vari Stati Europei, in alcuni casi assume invece un carattere patologico impoverendo le comunità locali delle risorse umane necessarie a mantenere lo sviluppo dei territori di origine.
Ecco allora che assume rilievo sul territorio l’avvio di una politica fiscale comune fra tutti i paesi europei non essendo possibile nemmeno concepire una comune politica industriale quando le imposte sulle imprese oscillano nei vari stati dal 40 al solo 4 per cento.
I diversi livelli retributivi potranno omogeneizzarsi in tempi non certo brevi ma anche qui occorre pensare ad un bilanciamento capace di correggere il dumping sociale che altera la concorrenza tra i diversi sistemi economici dei singoli Stati.
9. UNA STRATEGIA EUROPEA PER LE RISORSE ENERGETICHE
L’Europa non può perdere l’occasione di guardare al resto del mondo per realizzare la sua autonomia strategica. Ha goduto di un lungo periodo di crescita, benessere e attrattività legate all’invenzione del mercato unico che ha consentito ai Paesi aderenti economie di scala e produttività prima impensabili. Oggi, anche se ci sono margini importanti da utilizzare per portare a termine questo progetto, occorre associare al mercato unico una strategia industriale fondata sulle tecnologie digitali e l’innovazione, da realizzare in cooperazione con il resto del mondo.
È vero che l’Europa non è una federazione e la sua azione ha i limiti che nascono dall’essere un’Unione in cui gli Stati mantengono la loro sovranità, ma si può procedere a modifiche della Governance, anche senza metter mano a modifiche dei Trattati, procedendo tra i Paesi interessati ad adottare una strategia comune per superare questi limiti con il meccanismo delle “cooperazioni rafforzate”, che può consentire di disegnare un’Europa a “cerchi concentrici”. E si può infrangere la barriera delle decisioni all’unanimità con lo strumento delle “clausole passerella” che prevedono che il Consiglio europeo autorizzi, su singole materie, decisioni a maggioranza qualificata.
Occorre, dunque, fronteggiare la crisi geopolitica che domina la scena, tenendo conto delle transizioni in atto, da quella demografica a quella tecnologica, mentre si interviene per difendere l’ambiente e contrastare il cambiamento climatico.
Le transizioni in atto, a cominciare da quella geopolitica, mettono in gioco i rapporti tra le principali aree del mondo. L’Europa è quella che sta percorrendo una transizione di lungo periodo che l’ha portata, dai tempi in cui deteneva il primato dell’innovazione finanziaria e tecnologica, ad una situazione di ritardo nell’adozione delle nuove tecnologie.
È però pur sempre il continente che con la cultura, le invenzioni, le scoperte, le grandi esplorazioni geografiche ha, per un verso, influenzato e, per un altro, si è sempre connesso con il resto del mondo.È in questo contesto che l’Europa può ritrovare la sua missione richiamando la sua storia e la sua tradizione e proponendosi come leader tecnologico che mette a disposizione le sue competenze, come partner dei Paesi interessati. E, allo stesso tempo, ponendo la questione della correzione degli squilibri mondiali che si sono accentuati nel post globalizzazione.
Si può aggiungere che l’Europa può fare da battistrada anche perché, con il ritiro degli Usa dal multilateralismo e il venir meno del ruolo che consentì loro un ruolo dominante a Bretton Woods, c’è bisogno, per arrivare alla revisione di questi accordi, di un paziente dialogo e raccordo tra le visioni delle maggiori potenze e quelle dei Paesi emergenti e del sud del mondo.
È un ruolo che, per storia e tradizione, l’Europa potrebbe assumere se, nel frattempo, trovasse il modo di esprimersi unitariamente a livello internazionale.
Va tenuto presente che, a differenza dei combustibili fossili, la strada dell’energia rinnovabile richiede un forte investimento in infrastrutture e miglioramenti trasformativi, sia nella produzione, che nella distribuzione dell’energia. Occorrono tempi lunghi per questi cambiamenti. Non solo. La profonda trasformazione che ne segue rende ragione delle difficoltà che incontra oggi la transizione energetica di uscita dai fossili che, tuttavia, in Europa rimane la scelta di fondo confermata dalla Presidente von der Leyen a fine 2024.
La scelta europea di una transizione energetica fondata su una politica del Green Growth e, perciò, sostenibile, funziona solo se è alimentata dall’innovazione.
Sono necessari interventi che implichino una grande trasformazione del sistema produttivo, costi considerevoli e benefici certamente maggiori, ma apprezzabili soltanto in futuro. A ciò va aggiunto che l’aumento del costo dell’energia, iniziato poco prima dell’inizio della guerra in Ucraina ed esploso subito dopo, rappresenta uno snodo ancora irrisolto, anche se i progressi della tecnologia delle rinnovabili hanno reso conveniente il loro impiego.
Per raggiungere il necessario consenso tra i cittadini occorre, diversamente da quanto si è fatto finora, che questo percorso sia rappresentato in modo che sia chiaro come si intenda affrontarlo.
Il punto centrale è se le politiche climatiche, dirette a contrastare il cambiamento climatico, si possono realizzare senza sacrificare lo sviluppo economico, ciò è possibile con un uso appropriato di tasse sulle emissioni di carbonio e incentivi a favore delle energie rinnovabili che re-indirizzino il cambiamento tecnologico e sostengano l’innovazione a favore delle tecnologie “pulite”.
10. LA POLITICA MIGRATORIA
Se è vero che il mondo è da sempre in perenne movimento attraverso le migrazioni, fenomeno globale che esprime un’esigenza vitale dell’umanità, quella della mobilità, è anche vero che la sua accoglienza nei Paesi verso cui si dirige è tutt’altro che scontata.
Anzi oggi, sia negli USA che in Europa, la risposta dei cittadini attraverso il voto esprime una forte riluttanza ad accogliere gli immigrati.E questo pone un problema difficile da affrontare, ma alla cui soluzione, almeno in Europa, è legata la possibilità di realizzare uno sviluppo sostenibile.
Non sono nella giusta direzione le risposte che tendono a prevalere nei Paesi avanzati nei confronti dell’immigrazione. Non lo è quella che incoraggia i ‘sentiment’ contrari all’immigrazione, ma non lo è neppure quella che cerca di fronteggiare il malcontento in materia di immigrazione con misure di mero contenimento, che sono in buona sostanza incapaci di affrontare un fenomeno che è di portata epocale.L’Europa, se vuole mostrare il suo ‘forward looking’, deve valorizzare le sue tradizioni e i suoi valori di accoglienza e integrazione, investendo sugli immigrati, anche tenendo conto della caduta della natalità e della popolazione in età di lavoro che si accompagnano al suo invecchiamento. Deve trattarsi, perché possa sortire gli effetti necessari, di un investimento che nasca da un progetto che sia espressione dell’importanza dell’immigrazione per lo sviluppo europeo.La crisi demografica legata alla riduzione della popolazione e al suo invecchiamento, alla fine, renderà evidente l’esigenza di contare sull’immigrazione. L’Europa è stata capace di reagire in maniera unitaria alla crisi pandemica, varando un intervento di vasta portata. Può ed è dunque in grado di dotarsi di un grande progetto per l’immigrazione regolare con direttive e interventi che riguardino sia l’investimento sul capitale umano che l’integrazione degli immigrati. Per gli ‘irregolari’ che, a norma dei trattati internazionali vigenti, devono essere accolti, c’è bisogno di una normativa precisa che eviti le tante ambiguità di quella attuale e di un quadro che definisca i contorni generali di accoglienza e integrazione.L’analisi del rapporto tra costi e benefici dell’immigrazione depone a favore di questa scelta. Ma altrettanto accade se guardiamo all’altro lato, quello del rispetto dei valori europei. Essi vengono menzionati spesso, ma assumono tutta la loro evidenza se si parla dei valori dell’accoglienza che ne costituiscono il cuore, tant’è che, se fossero trascurati, saremmo di fronte ad un costo insopportabile, che è quello dell’abbandono dei principi che stanno a fondamento della stessa Europa.
Il problema migratorio è comunque connesso all’aiuto allo sviluppo dei paesi africani. In Africa, accanto alle aree di povertà, ci sono ormai molti Paesi che riescono ad avere una crescita significativa che si accompagna ad una forte urbanizzazione e all’affermazione di una moderna classe dirigente. La Ue ha avviato le sue iniziative a partire da Angola, Gabon, Rwanda, Sud Africa, Togo, Benin, Nigeria e Somalia.
L’Europa che, non va dimenticato, rappresenta il 55[[%]] degli scambi mondiali, può giocare un ruolo importante, forse decisivo, nell’assumere un’iniziativa internazionale per questo raccordo, sempre che riesca a dotarsi di una politica estera unitaria. Che è, peraltro, una priorità perché va tenuto presente che gli squilibri sono accompagnati da una scontentezza che vede unito il sud del mondo, Cina e Russia e che potrebbe facilmente trasformarsi in disordine globale.
[[*]] [[*]] [[*]]
È su questi temi che è necessario confrontarsi, e l’invito è rivolto in particolare ai cattolici italiani che è bene riscoprano il valore di un impegno politico unitario per rispondere ai tanti problemi di questa difficile epoca di transizione.
(Giulio Prosperetti)
MAP
No review yet.